Umanizzazione della macchina e/o macchina umanizzata?
Interrogativi cognitivisti sui possibili scenari futuri della scrittura a mano
DOI:
https://doi.org/10.4454/graphos.110Parole chiave:
computazionalismo, cognitivismo, Intelligenza artificiale, intelligenza umana, creativitàAbstract
Negli ultimi decenni, l’avanzamento delle tecnologie dell’intelligenza artificiale (IA) ha sollevato interrogativi tanto interessanti quanto pure allarmanti sulla possibile interazione tra la macchina e l’essere umano. Il saggio esplora il conflitto tutto pedagogico fra l’umanizzazione
della macchina e la macchina umanizzata nel contesto della scrittura a mano, ponendo interrogativi su come la tecnologia potrebbe influenzare questa forma di espressione umana alla luce del duplice e conflittuale paradigma computazionalista e cognitivista, e altresì alla luce del contrasto, molto attuale, fra la mente artificiale e la mente (almeno potenzialmente) creativa,
fra l’homo numericus (Cohen, 2023) e l’Essere (o l’esser-ci heideggeriano), fra la spontaneità grafico-scrittoria e l’artificio grafico-scrittorio, oggi sempre più diffuso.
L’avanzamento delle tecnologie fondate sull’IA e la continua evoluzione della scrittura digitale sollevano oggi più che mai interrogativi sulla natura dell’identità umana, dell’autenticità esistenziale e della creatività. Se, da un lato, questo ormai inderogabile sviluppo ipertecnologico porta a nuove, quanto inevitabili forme di espressione, d’altro canto, pone un certo agire
educativo, formale e non formale, dinanzi a una sfida pedagogica intenta a definire i confini tra l’opera umana, quella scrittoria in particolare, e l’opera generata dalla macchina, e intenta pure a contemplare una futuribile loro possibile e funzionale interazione.
Riferimenti bibliografici
Anderson H.H. (1972). La creatività e le sue prospettive. Brescia: La Scuola.
Benanti P. (2017). Postumano, troppo postumano. Roma: Castelvecchi.
Bruner J. (1996). La cultura dell’educazione. Milano Feltrinelli (tr. it. 1998),
Cohen D. (2023). Homo numericus. Roma: Anicia.
Crépieux-Jamin J. (1950). ABC de la graphologie. Paris: Presses universitaires de France (tr. it. 2001).
Csikszentmihalyi M. (1988). Optimal Esperience. New York: Cambridge University Press.
Csikszentmihalyi M. (1997). Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York: Harper Perennial.
Csikszentmihalyi Mihaly (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper and Row (tr. it. Flow. Psicologia dell'esperienza ottimale. Macerata; Milano: Roi, 2022).
de Ajuriaguerra J. (1989). L’écriture de l’enfant. Tome 1. Neuchătel: Delachaux & Niestle.
Filograsso N. (1995). H. Gardner. Un modello di pedagogia modulare. Roma: Anicia.
Filograsso N. (1997). Dilemmi dell'educazione nella società acentrica. Urbino: QuattroVenti.
Filograsso N. (2008). Lezioni di psicopedagogia. Milano: FrancoAngeli.
Fromm E. (1972). L’atteggiamento creativo. In H.H. Anderson, La creatività e le sue prospettive. Brescia: La Scuola, pp. 67-78.
Fromm E. (1987). Fuga dalla libertà, Mondadori, Milano (ed. orig. 1941).
Fromm E. (1996). L’arte di vivere. Mondadori, Milano.
Gardner H. (1988). La nuova scienza della mente. Storia della rivoluzione cognitiva. Milano: Feltrinelli (ed. orig. 1987).
Gardner H. (1997). Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza. Milano: Feltrinelli (ed. orig. 1983).
Gardner H. (2004). Riflessioni sulle intelligenze multiple: miti da sfatare e messaggi da trasmettere. In M. Baldacci, A. Giallongo, P. Gaspari, C. Marini e R. Travaglini (a cura di). Educazione e civiltà. Studi in onore di Nando Filograsso. Roma: Anicia, pp. 67-82.
Gardner H. (2022). La mente sintetica.
Klages L. (1982). La scrittura e il carattere. Milano: Mursia.
Lowen A. (1984). Il piacere. Un approccio creativo alla vita. Roma: Astrolabio (ed. orig. 1979).
Maslow (1971). Verso una psicologia dell’essere. Roma: Astrolabio.
Maslow (1972). La creatività nell’individuo che realizza il proprio io. In H.H. Anderson, La creatività e le sue prospettive. Brescia: La Scuola, pp. 111-124.
Minsky M. (1989). La società della mente. Milano: Adelphi.
Moretti G.M. (2006). Trattato di grafologia. Quindicesima edizione. Padova: Messaggero.
Peugeot J. (1985). La conoscenza del bambino attraverso la scrittura. Brescia: La Scuola.
Rogers C. (1972). Per una teoria della creatività. In H.H. Anderson, La creatività e le sue prospettive. Brescia: La Scuola, pp. 95-110.
Rose S. (1994). La fabbrica della memoria. Milano: Garzanti.
Travaglini R. (2014). Motivarsi ad apprendere. Roma: Aracne.
Travaglini R. (2023). Comprendere i “lati oscuri” della scrittura (manuale). Graphos. Rivista internazionale di Pedagogia e didattica della scrittura, II, 2, pp. 23-33.
Treccani, vocabolario online. Disponibile in https://www.treccani.it/vocabolario/intelligenza/?search=intellig%C3%A8nza%2F
Urbani P. (2021). Immaginare la scrittura perfetta. Un’utopia tra ragione e passione. Roma: Epsylon.
Downloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2024 Roberto Travaglini

TQuesto lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.
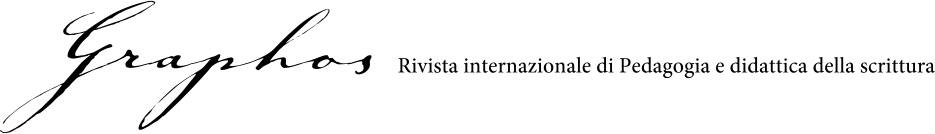



 Edizioni ETS s.r.l. LUNGARNO MEDICEO 16 - 56127 - PISA
Edizioni ETS s.r.l. LUNGARNO MEDICEO 16 - 56127 - PISA